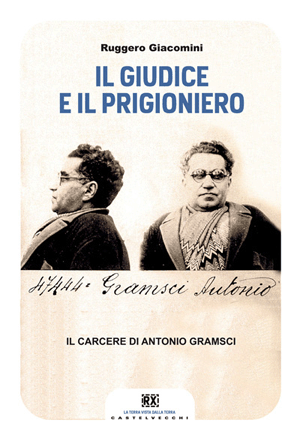|
Ruggero Giacomini, Il giudice e il prigioniero. Il carcere di
Antonio Gramsci
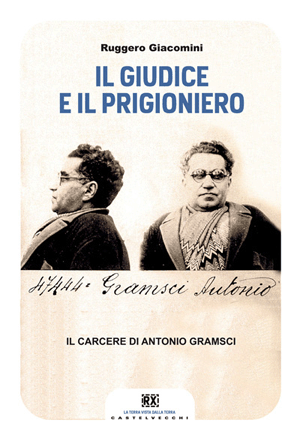
di
Alexander Höbel
Il libro di Ruggero Giacomini su
Gramsci e sulle strategie del potere che lo deteneva in carcere
costituisce una precisa e utile messa a punto su una serie di
questioni di cui in questi ultimi anni si è molto discusso: il
carcere di Gramsci, il suo rapporto col Partito e con
l’Internazionale, il procedere della sua elaborazione. Il volume di
Giacomini, tenendo conto della vasta bibliografia su questi temi, vi
apporta un contributo originale, basato su fonti archivistiche
finora trascurate o non del tutto analizzate.
Negli ultimi anni, a proposito della vicenda carceraria di Gramsci,
si è tornato a discutere della famosa (o “famigerata”) lettera di
Grieco, che il giudice Macis pose all’attenzione del prigioniero,
instillandogli il sospetto di una sorta di complotto ai suoi danni.
Molto poco però si era finora esaminata la figura del giudice, e
invece proprio la ricostruzione del suo percorso biografico da parte
dell’Autore rappresenta uno dei primi meriti del libro. Macis ne
emerge come un uomo ambizioso, spregiudicato e scaltro, che briga
per ottenere il posto di giudice istruttore militare pur non avendo
superato il concorso – e riesce infine a spuntarla –, poi entra a
far parte del Tribunale speciale fascista, e in questo ambito si
rivelerà zelante esecutore, ma anche protagonista, della manovra
contro Gramsci imbastita dall’OVRA e dagli apparati fascisti,
utilizzando la lettera di Grieco dopo essersi conquistato la fiducia
del prigioniero fingendo di essere “super partes” e simulando una
inesistente conflittualità fra Tribunale speciale e organi di
polizia, e ottenendo poi premi e avanzamenti di carriera per il
“lavoro” svolto. Lo stesso Macis insabbia l’inchiesta sulla bomba
alla Fiera di Milano, che serve al fascismo per un’ulteriore stretta
repressiva; nel 1935 parte volontario per l’Africa – sempre come
giudice militare – e nella seconda guerra mondiale sarà nella
Slovenia occupata dai fascisti, dove pure si mostrerà zelantissimo,
finendo nell’elenco dei criminali di guerra di cui la Jugoslavia
chiederà l’estradizione. Ma incredibilmente Macis riesce ad
acquisire una “patente” di antifascista, per il solo fatto di non
aver prestato servizio per la Repubblica sociale, ottenendo infine –
grazie alla mediazione di un esponente di Giustizia e Libertà –
addirittura la qualifica di “gregario” partigiano… Un esito
sconcertante, ma che si colloca in un percorso per molti aspetti
emblematico, che dice molto sulla continuità dello Stato, di uomini
e apparati, e sul trasformismo delle classi dirigenti e di tanti
loro funzionari.
Di fronte a questo giudice, il prigioniero appartiene a un altro
mondo morale, a un altro universo di valori, totalmente contrapposto
e inconciliabile, anche se Gramsci stesso in alcuni momenti pare
quasi dimenticarlo, finendo per cadere vittima del suo avversario
che si presenta sotto le mentite spoglie di un quasi alleato. Di
fronte a Macis e a tutto il sistema di potere fascista, Gramsci
appare ancora di più come un gigante, dotato di una forza
straordinaria che gli proviene dai suoi ideali e dalla convinzione
che con il proprio modo di agire egli debba dare un esempio a tutti
i militanti, i lavoratori, gli antifascisti (e anche questo – spiega
Giacomini – contribuisce al ritardo di quella partenza che avrebbe
forse scongiurato l’arresto, cosa che non avvenne perché Gramsci
doveva parlare alla Camera contro le leggi eccezionali), e che gli
consente di sopportare, con quella che l’Autore giustamente
definisce una “resistenza eroica”, le torture psicologiche e non
solo dei suoi carcerieri.
Giacomini infatti ci restituisce la materialità della condizione di
detenuto di Gramsci e le strategie del potere fascista volte a
fiaccarne la resistenza, cosa di cui egli stesso è consapevole. Le
guardie carcerarie – dice Gramsci a un compagno di prigione,
Giovanni Lay – sono “strumenti di un potere che sa quel che vuole da
noi. Che rinunciamo ad essere dei combattenti, che ci umiliamo”
(pag. 206). Di qui un insieme trattamenti che si configurano come
vera e propria tortura, sebbene “a bassa intensità”: i rumori
notturni per impedire a Gramsci di dormire procurandogli un forte
esaurimento nervoso; prima ancora, le incredibili modalità del
trasferimento da Ustica a Milano e di lì a Turi, che gli provocano
un “fuoco di sant’Antonio”; appena giunto in carcere, la
sistemazione in una cella con quattro ammalati di tubercolosi; fino
ad arrivare al cibo con insetti che gli sarà servito alla clinica
Cusumano, e soprattutto alle mancate cure di fronte a uno stato di
salute che andava costantemente deteriorandosi.
Ma la tortura è anche psicologica e ha l’obiettivo di far sentire a
Gramsci una condizione di isolamento, di distanza dai suoi cari e
dal suo partito, per indurlo infine a cedere, a presentare quella
richiesta di grazia che costituiva l’obiettivo precipuo di Mussolini
e che per il dirigente comunista sarebbe equivalsa – sono le sue
parole – a “un suicidio”, e che è dunque ciò che egli cerca di
evitare – e vi riesce – con tutte le sue forze. Dal libro di
Giacomini emerge cioè in modo chiaro quel contrasto insanabile di
volontà che caratterizzò tutta la vicenda carceraria di Gramsci,
concludendosi con la morte (ma anche, paradossalmente, con la
vittoria) del prigioniero.
In questo contesto l’Autore colloca l’azione di provocatori come
Romani, Scucchia e altri, che mira a separare Gramsci dagli altri
detenuti politici. E in questo quadro c’è la strumentalizzazione
della lettera di Grieco, che – scrive Giacomini – “fu un’arma usata
contro Gramsci per cercare di staccarlo dal suo partito, isolarlo,
demoralizzarlo”, spingerlo a fare richiesta di grazia. Al
prigioniero il giudice Macis fece credere che la lettera stesse
influendo negativamente sulle sue sorti: non tanto nel processo –
come pure si continua a scrivere – visto che l’istruttoria si era
già conclusa (e non a caso la lettera di Grieco non è tra gli
incartamenti processuali), quanto nel far fallire la trattativa in
corso per la sua liberazione, di cui però – come Giacomini dimostra
– Grieco e Togliatti erano ignari, poiché essa era stata tentata dal
governo sovietico con la mediazione del Vaticano attraverso uno
scambio di prigionieri col governo italiano ma era stata stroncata
da Mussolini in persona nell’ottobre 1927, mentre la lettera risale
al marzo 1928.
La missiva di Grieco dunque non influì sull’istruttoria – già chiusa
il 20 febbraio 1928 – né sulla trattativa, arenatasi già prima. Di
quest’ultima cosa, però, come rileva l’Autore, Gramsci non era a
conoscenza. Di qui, e in seguito alle provocatorie allusioni di
Macis, i suoi sospetti, che poi diventeranno i sospetti di Tania e
delle altre sorelle Schucht, fino a giungere ai vertici del
Comintern, provocando una sorta di inchiesta su Togliatti (e su
Grieco), che finirà in una bolla di sapone.
La cosa per certi versi stupefacente, però, è che questi sospetti –
su cui già negli anni Settanta le ricerche di Paolo Spriano avevano
fatto chiarezza – sono poi giunti fino a noi, alimentati da libri
più o meno fantasiosi, che non hanno portato alcun nuovo elemento di
fatto, basandosi perlopiù su ipotesi e interpretazioni, spesso anche
distorcendo i fatti stessi. Di qui le illazioni sui “due carceri di
Gramsci” (quello fascista e quello comunista), o sulla sua presunta
“rottura col comunismo”, col Pcd’I, con l’Urss, con
l’Internazionale.
Al contrario, ciò che gli studi scevri da pregiudizi confermano è
proprio la persistenza del legame tra Gramsci e quello che era il
suo mondo; un legame organico, che resiste fino alla fine della vita
del prigioniero, e certamente biunivoco. Da parte del movimento
comunista, dell’Urss e del partito italiano, Gramsci non sarà mai
abbandonato, come dimostrano i ripetuti tentativi di trattativa per
la sua liberazione, le campagne stampa internazionali (e Giacomini
dimostra come quella legata alla pubblicazione del rapporto del dr.
Arcangeli ebbe solo effetti positivi, contribuendo al trasferimento
di Gramsci dal carcere di Turi alla clinica Cusumano di Formia), lo
stesso pagamento delle costose cure mediche, effettuato dal
Comintern tramite Sraffa.
D’altro canto, il legame resta vivo anche da parte di Gramsci, che a
Turi continua a operare come un dirigente del partito – e a tale
proposito è molto bello il capitolo sulle “lezioni di Turi”, il
corso di formazione che il leader comunista riesce a organizzare in
carcere nel 1931 –, e in questa veste rilancia la proposta
dell’Assemblea Costituente come parola d’ordine sulla base della
quale costruire alleanze e contribuire alla caduta del fascismo, coi
comunisti che avrebbero dovuto avere un ruolo di avanguardia,
continuando poi a lavorare nell’ambito della rivoluzione democratica
per rendere possibile una prospettiva socialista. Non si tratta
dunque di una conversione di Gramsci alla democrazia senza aggettivi
o dell’abbandono degli obiettivi rivoluzionari, ma piuttosto di una
strategia simile a quella usata dai bolscevichi nel febbraio 1917 e
a quella che Togliatti, Longo e Secchia porteranno avanti nel
1943-47, dalla Resistenza alla svolta di Salerno, all’Assemblea
Costituente effettivamente conquistata nel 1946. In questo senso, il
contributo decisivo di Gramsci alla storia anche successiva del Pci
e alla strategia della “via italiana al socialismo” risulta
ampiamente confermato.
Né Gramsci “rompe” con l’Urss o col Comintern. Il rapporto con
Sraffa è per lui anche un canale diretto col movimento comunista; e
ancora nel 1937, il paese per il quale il prigioniero presenta
domanda di espatrio è l’Unione Sovietica.
Tutto ciò non significa che siano mancate differenze di vedute tra
Gramsci, il partito italiano, quello sovietico, l’Internazionale.
D’altro canto, proprio chi pensa che ogni divergenza implichi
necessariamente una rottura mostra di avere una concezione
“monolitica” del movimento comunista, la cui vita e la cui
articolazione sono molto più complesse. Significa invece che Gramsci
rimase fino alla fine un militante e dirigente comunista, e proprio
a questa sua identità, a questo carattere fondamentale del suo
essere attribuì un’importanza maggiore della vita stessa. È dunque
il rispetto che si deve alla sua figura e alla sua memoria che
imporrebbe, o almeno suggerirebbe, di evitare ricostruzioni
fantasiose volte a negare questo elemento. Il libro di Ruggero
Giacomini contribuisce invece a documentare tale acquisizione, e
dunque a consolidarla, e questo non è certo il minore dei suoi
meriti.
|
|